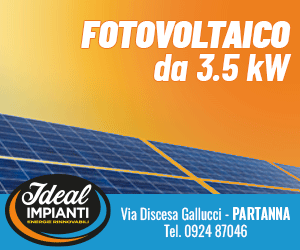[Inauguriamo una stagione estiva ricca di esclusivi inserti culturali! Attraverseremo questi mesi di canicola in compagnia di scrittori, filosofi e artisti perché le nostre giornate in spiaggia possano trovare come vicini d'ombrellone nuovi luoghi da scoprire, nuove pagine da leggere, nuovi pensieri da abitare.
A dare il via sono Domenico Conoscenti e Vanessa Ambrosecchio, tra i maggiori romanzieri italiani di oggi. Aprono la rubrica Autori allo specchio, in cui due scrittori raccontano l'uno l'opera dell'altro. Fuori dalle logiche della critica letteraria o della recensione occasionale, in questi articoli - che leggerete oggi e domani - ognuno di loro riflette e ritrova sé stesso nell'opera dell'altro, entrambi convinti che i libri non siano altro che specchi che quotidianamente ribaltano o ci riappropriano dell'immagine che abbiamo di noi.]
di Domenico Conoscenti
Il primo contatto con la scrittura di Vanessa Ambrosecchio è avvenuto attraverso la sua voce. L’ho ascoltata leggere un racconto, Lunga sulla schiena, a scatti ravvicinati, in un tono energico, a volte un po’ teatrale: un’esecuzione che si è insinuata come una possibile chiave interpretativa del suo rapporto con la scrittura narrativa. Chiave confermata poi nel corso della frequentazione dei testi dell’autrice, e tuttavia valida a condizione di precisare che il lavoro sulla “poetizzazione” della lingua dei racconti subisce una sorta di impennata progressiva nei due romanzi, alla quale ne corrisponde un’altra, più vigorosa, del livello metaforico delle storie raccontate. Unica, netta eccezione a questa partizione generale è Vent’anni e la pioggia, racconto che appare come un frammento, reso autonomo, di Cosa vedi e per il quale potranno valere le considerazioni fatte a proposito del romanzo. Caso a sé stante è invece Good morning Palermo, racconto che, sia per lo stile che per la trama, si colloca in un punto intermedio fra il blocco dei quattro racconti e quello dei due romanzi (e di Vent’anni e la pioggia).
Non credo si possa trattare di un caso di imprinting, però nella mia dilazionata lettura dei sei racconti, i miei preferiti, i più compiuti e originali per me sono quelli che condividono con Lunga sulla schiena l’ambientazione palermitana. Fra questi Good morning Palermo, che potrebbe leggersi come una sorta di indipendente variazione in minore (“minore” per le dimensioni), non saprei se più precursione o digressione in itinere, di Cosa vedi, il romanzo più recente; o forse come un tentativo di avvicinamento, in tonalità più lieve e luminosa, ad uno dei suoi nuclei tematici.
Se in Lunga sulla schiena i fatti sono materialmente inscindibili dai luoghi della borgata dell’Arenella e dei cantieri navali, resi con descrizioni vivide, mai banali, in Good morning Palermo la città diventa tema problematico in sé, nucleo portante della costruzione narrativa. Palermo, ancora riconoscibile in quest’ultimo racconto, sia pure attraverso uno sguardo onirico e spiazzante, nel secondo romanzo si trasforma in un vasto cantiere di scavi, trincee e recinzioni, che ne ha già sconvolto l’aspetto e che procede ostinato nella sua opera di demolizione, rimozione e omologante ricostruzione. Ci troviamo di fronte a una lettura simbolica della storia politica (nel senso ampio del termine) e sociale della città, grosso modo degli ultimi decenni, con le stragi del 1992, con i nefasti sconvolgimenti che si sono intrecciati alla storia nazionale e con gli scatti di orgoglio che pure hanno generato nei suoi abitanti. Con tutto ciò, la città rimane a livello della trama anche scenario attivo degli opachi, cangianti rapporti che intercorrono fra Hagar, Aureliano e Dana. La mescolanza di luoghi reali (la Galleria delle Vittorie, nel suo attuale stato di abbandono, o le recenti costruzioni in granito alle spalle del Palazzo di Giustizia) e dei non-luoghi immaginati gioca un ruolo centrale nel rendere l’atmosfera del romanzo: caleidoscopica ed enigmatica, riluttante a qualunque approccio naturalistico.
Nel suo primo romanzo, Cico c’è, ambientato a Venezia, lungi ugualmente da svolgere il ruolo di (abusato) artistico fondale, la città appare la trascrizione, in altro linguaggio, del corpo, del sesso femminile con i suoi flussi e i canali, i fluidi stagnanti e i bacini, luogo fisiologicamente, contemporaneamente, deputato allo spurgo e alla procreazione, con l’intensa problematicità cui rimanda il tema della maternità attraverso i tre personaggi più importanti (femminili, ça va sans dire) della narrazione, refrattaria anch’essa non solo a una interpretazione immediatamente realistica, ma anche ideologica o patetica; una refrattarietà inequivocabile dalla seconda parte in poi e che non rinuncia a occasionali barlumi di ironia. La centralità dell’acqua, delle acque, nell’universo immaginifico dell’autrice, evidente in Cico c’è, la si era già intravista, pur con valenze descrittive e metaforiche molto diverse, in Lunga sulla schiena, finendo per creare un implicito trait d’union fra due testi del tutto differenti.
Palermo infine è presente per cenni, come dato denotativo, anche nei racconti non citati in questo paragrafo, tranne che in Piove, ambientato in una astratta, “tipica” città.
Le onde sincopate di Lunga sulla schiena, messe in risalto dalla lettura dell’autrice e presenti a livelli diversi nella quasi totalità degli altri testi, non sono l’unico tentativo di avvicinare la scrittura a una dizione poetica. Concorrono a questo aspetto fonico la scansione sintattica di certe frasi, ellittiche o scorciate sulla falsariga del parlato (“Tirarsene fuori, pensavo”, “Palermo, bisogna starci stranieri”, “Chissà Mondello, a quest’ora”), non tanto con intenti di mimesi ma, appunto, di ritmo, e al tempo stesso di condensazione del significato. A farsi carico di potenziare e variare quest’ultimo effetto concorre soprattutto l’inserimento frequente di metafore, di figure retoriche dello spostamento o di termini scelti per intuizione analogica, molto più evidente nei romanzi, in particolare (e fin dall’incipit) in Cosa vedi, a testimonianza della cura riservata da Ambrosecchio a forgiarsi un proprio, personale linguaggio espressivo.
Per restare in ambito cittadino, i nomi che mi vengono in mente come possibili autori consonanti nella creazione di questo peculiare, straniante mondo tematico-espressivo sono quelli della cosiddetta Scuola di Palermo all’interno del Gruppo ‘63 (Michele Perriera e Gaetano Testa in primis) e gli animatori-autori della casa editrice Perap (tra cui Francesco Gambaro), preferiti nella tonalità seria, pensosa o drammatica, non in quella ludico-dadaista. Dilatando i confini spazio-temporali, mi spingerei indietro verso le avanguardie storiche (Futuristi e Surrealisti) e in generale verso la poesia e il romanzo francesi del secolo scorso (soprattutto in relazione a Cosa vedi, aperto non a caso da una citazione di Paul Eluard), giungendo a Michel Butor e all’Ecole du regard degli anni Sessanta. Insieme alla ricerca di innovazioni espressive, Ambrosecchio condivide con gran parte di loro una concezione decisamente antinaturalistica della narrazione, mentre, da questo punto di vista, discorso diverso va fatto per molti dei racconti: mi riferisco a Dagguanno, Milton è vivo, Lunga sulla schiena, nei quali spiccano la capacità di narrare verosimilmente, ad esempio, il mondo degli adolescenti, fuori e dentro la scuola, oppure a Piove, che si concentra sulla scansione al femminile di una giornata.
La funzione “sociale”, “politica” del romanzo tuttavia non viene cancellata, come già anticipato a proposito di Cosa vedi e di Cico c’è: si ripropone come sguardo critico allucinato o surreale, a tratti ipnotico sulla realtà effettuale del qui e ora, lasciandone intuire una diversa, possibile modalità di esistenza, senza tuttavia giungere a descriverla o a definirla in qualche modo. La centralità data al linguaggio, d’altro canto, corre il forte rischio di polarizzare su di sé l’attenzione e di porre in ombra l’aspetto narrativo del romanzo, se non di vampirizzarlo. Tale centralità, accesa nelle zone descrittive e riflessive del testo, si riscontra anche in quei dialoghi e monologhi (Cosa vedi è di fatto un lungo monologo in cui spicca la prima persona) che dovrebbero farsi carico di sviluppare la trama, la quale in tal modo non può che risultare altrettanto elusiva, ellittica anch’essa, sfaccettata come un dipinto cubista o riflessa da uno specchio scheggiato.
I romanzi in particolare si presentano come un gioco di specchi. Venezia, la città-utero che include nella sua identità il proprio riflesso lagunare, in Cico c’è accoglie al proprio interno i movimenti di personaggi (Rachele) costruiti su una vicenda in cui inizio e fine fatalmente si rispecchiano; o di episodi che vedono rimandarsi-contrapporsi i punti di vista di Mariù e di Erina, scissi ulteriormente in quelli di Mariù e sua madre, e di Erina e sua madre, in una tensione speculare che sembra talvolta allentarsi senza tuttavia sciogliersi mai. In Cosa vedi il gioco del doppio si complica ulteriormente: posto in sé dal tema dell’immagine fotografica come specchio della realtà e dal particolare confronto tra l’“oggettività” della foto (che nasconde e rivela) e l’ambiguità dell’oggetto fotografato, esso viene rafforzato dal personaggio di Dana: contraddittorio, a tratti scisso (come del resto gli altri personaggi del romanzo, eccezion fatta forse per Hyppolite), virtuale doppio di Liv, la donna che ha avuto un ruolo decisivo nel vissuto del protagonista. Gioco potenziato ancora dalla coppia Hyppolite e Hagar, quasi una riproposizione – meno angosciosa ‒ del dottor Jeckill e Mister Hyde, fino ad Hagar stesso, duplice già nel ruolo di narratore- protagonista, spaccato fra il passato di fotografo politicamente impegnato e un presente di sopravvissuto a sé stesso, tutto sarcasmo e dolente disincanto, schizofrenico quasi quando lo ascoltiamo formulare l’esatto contrario di quanto espresso appena prima. Ambivalenza schizofrenica, dei personaggi e della voce narrante, ancora più abbagliante nella manciata di pagine di Vent’anni e la pioggia.
Un dedalo di specchi da cui non è concesso fuggire ai personaggi che vi si aggirano. Nemmeno al lettore (ammesso che abbia voglia di farlo), ancora a lungo dopo avere girato l’ultima pagina.

 Sezioni
Sezioni


















 "Ecco perchè mi mandarono via"" >
"Ecco perchè mi mandarono via"" >