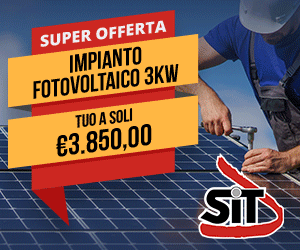di Gianfranco Perriera
Folle che sciamano rumorose tra le sale, scattandosi foto a vicenda senza soluzione di continuità, così Jean Clair – storico e critico d’arte, direttore di musei e di festival dallo sprezzante gusto d’antan – descriveva, ne L’inverno della cultura, lo stato dell’arte per quanto riguarda la ricezione contemporanea, nel tempo cioè del rumore e della percezione di massa, distratta e bulimica. Una ridda scoppiettante si muove nei saloni, sfiorata qualche volta dal sospetto “che neanche lì [nei templi/magazzini dell’arte] ci si possa aspettare qualcosa”.
A qualche anno di distanza dal libro di Clair, con minore sprezzo, ma con altrettanta sagacia e accuratezza filologica ed interpretativa, Piero Violante ci consegna il suo Lo spettatore musicale, per i tipi della Sellerio. Centrato assai più sull’orecchio – curioso, in effetti, come la “scienza” della percezione e del gusto, l’estetica, nasconda nel suo etimo un riferimento all’orecchio: è forse attraverso il suono, attraverso la parola, dunque, che si affina davvero il nostro sentire e parlare? – ma non soltanto su esso, piuttosto che sullo sguardo, il libro è una raccolta di saggi che analizza e tematizza la storia e la deriva del moderno attraverso quasi un secolo di musica, dalla Vienna fin de siècle alle esperienze novecentesche di Morton o Haas. Con Adorno come nume tutelare, Violante sottolinea come il critico musicale debba saper contemperare “l’autonomia della forma artistica sì, ma insieme (l’)interrelazione sociale”. Non pura soggettività emotiva della ricezione, dunque, ma anche consapevolezza “dell’evoluzione interna del canone musicale in sé”, riconoscendo anche il carattere di “sintomo sociale” proprio dell’opera musicale: tali le prerogative di una critica avveduta.
Il moderno è tempo di crisi e lo spettatore musicale, precisa Violante, “si affida all’intuizione centrale che la musica con l’affermarsi del moderno sia un elemento di crisi”. L’autore sa bene che nella sarabanda cacofonica e cacoinformazionale (mi si passi il neologismo) il compito dello spettatore consapevole, dell’intellettuale in genere, è sempre più difficile e indigesto ai più. “Mezzo secolo di grandi e piccole trasformazioni anche nell’organizzazione musicale – ci avverte – […] l’ingresso nel ruolo di sovrintendente di manager che a volte ignorano che la musica non sia un diversivo, ma elemento della Bildung individuale e collettiva” hanno sostanzialmente dissipato la funzione critico-educativa della musica. Ma l’intellettuale -questa Cassandra che rischia di esser fatta serva del potere e che pure non rinuncia a leggere nel reale i segni dello svilimento o peggio della catastrofe dell’umano – insiste nella sua opera di scavo e di interpretazione, rifuggendo il ruolo di “intellettuale velina” e non abdicando, invece, “alla funzione di mediazione e di critica”, malgrado “sui giornali la critica venga ultima dopo il pezzo di colore”.

Un filo, luminoso e ricco di variazioni, annoda i saggi che compongono il volume: il moderno si è trasformato in un vertiginoso lapsus, uno scivolone che trascina nell’abisso – nei forni crematori, persino – la speranza di gentile redenzione dell’umano che in origine lo connotava, consegnandoci alla ferocia tecnocratica e imbestiata del lager. Non a caso è da un lapsus che prende avvio il volume. Quell’improvvido eppure rivelatore errore per cui Kafka pone sul braccio della Statua della Libertà all’inizio del romanzo America “non la fiaccola pe illuminare il Progresso”, ma una spada. Un arcangelo minaccioso accoglie Karl, Il protagonista, all’arrivo al porto di New York. Minaccia un tempo di espulsioni e di vessazioni e perdizione. Il soggetto, in effetti, smarrito ogni titanismo alla Beethoven, sommerso dall’anonimato della folla, soffocato dal caos del traffico, mercificato dallo scambio monetario, rischia se non di evaporare, di risolversi in un unico compito: “far sopravvivere la sua individualità destinata all’anonimato attraverso un’estetizzazione del sé”. Sempre più labile, o peggio circuito dalle fanfare della guerra o del populismo nazionalista, il soggetto cerca di sfuggire al naufragio attraverso la sensibilità del distacco critico.
Dalla delicata levità di Schubert, che “ci fa assistere al naufragio della soggettività come produttrice di senso” a Schoenberg che “ha preso su di sé tutte le tenebre e le colpe del mondo” e che in A Survivor from Warsaw, mentre non cede alla rimozione del senso di colpa che i tedeschi e il mondo intero vorrebbero conseguire, conclude l’operina di otto minuti con l’irruzione liberatoria dell’inno Shema Israel, “che ridà la parola al popolo di Mosè”; dall’utilizzo che Hitler fece della mitologia totalitaria delle opere di Wagner, “puntando decisamente sull’antisemitismo come elemento identitario contro la democrazia” alle dolorose sinfonie di Mahler, che, nel loro insieme, “sono un labirinto stratificato di una esemplare, universale, biografia infelice. Come se Mahler si proponesse di imporre la valenza universale della soggettività danneggiata”; dalla ossessività demonica delle marce militari e dall’universo concentrazionario del lager dove il moderno ha espresso tutto il suo veleno spingendosi sino alla totale negazione dei diritti dell’uomo fino all’indistinto di In Vain di Georg Friedrich Haas, per cui “la via della verità arriva dal buio”, il volume, senza nascondersi l’ambiguità dell’opera musicale (e dell’opera d’arte in genere), non smette mai di suggerirci le qualità critiche e insieme etiche che contraddistinguono la più profonda creazione artistica. Non passatempo, non festa per spettatori ad occhi chiusi, emotivamente coinvolti, a volte certo anche connivente, ma mai neutral’arte e, quando davvero profonda e complessa, essa si fa consapevolezza critica e ferita aperta sul dolore del mondo.
Brio narrativo, ricchezza di riferimenti bibliografici, raffinate intuizioni interpretative si combinano in questi godibilissimi saggi a rammentarci che l’arte, anche in un’epoca convulsa e sciamannata, purché non si rinunci alla mediazione del pensare, non stenderà mai un velo pietoso sulle catastrofi che i tempi volessero imporci. Quando impazzava la psicologia fenomenologica/esistenziale si conveniva sul fatto che, ingabbiati in una quotidianità caotica e accelerata, gli umani avessero perduto il senso dell’essere e del nulla e soltanto l’incontro con i malati avrebbe potuto risvegliarli dal torpore dello spirito e dell’intelligenza. Non ai malati, ma all’intelligente ascolto della musica – che certo in quanto colta non gode di florida salute – con in più la nostalgica consapevolezza che dopo Auschwitz è arduo “far poesia, fa appello Piero Violante, per risvegliare la nostra anima a un più gentile e più generoso senso dell’esistere".
 Sezioni
Sezioni



















 "Ecco perchè mi mandarono via"" >
"Ecco perchè mi mandarono via"" >