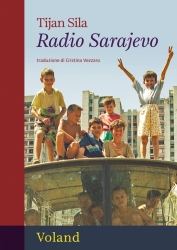di Gianfranco Perriera
“Anche tu, anche tu, anche tu/ – incalzava tre volte Magnus Ezensberger in Bildzeitung - arriverai lentamente/ alle busta paga e alle bugie”. Eravamo poco più che alla metà degli anni cinquanta e il poeta tedesco, con lucido e sprezzante sarcasmo, svergognava il rinsecchirsi di ogni anima (tornata pericolosamente “piccolo borghese”) nel grigiore del quotidiano e negli opportunismi – quand’anche risicati – dell’arricchimento materiale. Sono passati, quindi, quasi settant’anni e – pur nello scintillio del vetrinismo che ha accompagnato lo scorrere del tempo – la sensazione di scolorimento e di intichisimento dello spirito non è certo diminuita. Settant’anni quasi sono passati e un’ironia più lieve ma altrettanto brio, un simile piacere nel mescolare antiche voci a termini ultramoderni trascelti anche da linguaggi specialistici, l’acuto sentire e l’intenso giocar di fonemi che avverte il mondo e l’esperienza del suo annebbiarsi, si riscontrano nell’ultima raccolta di versi di Nicola Romano, Tra un niente e una menzogna, edito da Passigli. Scrollarsi di dosso questa cappa di infausto torpore, sgramagliarsi da un’epoca di ciniche e mortifere bugie: a ciò, mi pare, invitano i versi di Romano. “Per scrivere poesie/ - scrive l’autore in Le Poesie – bisogna frequentare il vuoto/la durezza dei muri/ il farfugliare assurdo/ dei chiromanti”. Auscultare la parola che possa riaprire un orizzonte non è opera da poco: è necessario, perciò, frequentare il vuoto, non negarsi alla mancanza, al rischio di precipitare nell’assenza di mondo; è necessario sbucciarsi la voce e la pelle sull’asperità delle barriere che impediscono lo sguardo; è necessario districarsi nel rumore delle chiacchiere più stralunate o dei presagi più confusi. Soprattutto, per scrivere poesie ci suggerisce Romano, non è più tempo di voli alati in cieli pieni di gloria. Bisogna volgersi alla terra, piegarsi, giù, sino alla terra, “bisogna – conclude la poesia – genuflettere l’anima/ ascoltando un album di Endrigo/ e lavarsi i capelli/ con la residua cenere del mondo”. Una scabra malinconia e l’abluzione col secco residuo di mondo: questo tocca a chi vuol esser poeta. Per non arrendersi all’oblio, probabilmente. Per questo bisogna essere persino barboni, perché “su lemmi di cartone/stanno smunte parole/tenute con lo spago/quando debole appare e senza voce/l’armonia che nutrire vuole un canto” (Poesia barbona). L’enjambement, con sottile perizia, si sofferma su lemmi che richiamano il dettare del poeta, intervallati da termini che richiamano il materiale povero, quasi da bricolage (cartone, spago) con cui l’artefice, per come i tempi bui gli concedono, si prova a far risuonare un canto. E’ quasi un rabberciare, dunque, l’opera del poeta a cui Romano ci richiama. Mi tornano in mente le parole di Simone Weil: “l’infinito che è nell’uomo è alla mercé di un frammento di ferro”.
Perlustrare tra le zone d’ombra, tra gli stessi scarti, le dimenticanze e le trascuratezze del tempo, tra gli sfilacciati ricordi è il mestiere dell’ironico ma infaticabile peregrinatore che è un poeta. “Ho trovato/ degli avanzi di luna/ sulla tovaglia del mare”, scrive in Flutti di mare. Quante liriche, in effetti, sono state scritte sulla luna e sul mare. Ma Romano ci ricorda che scrivere è recuperare suggestioni, emozioni, pensieri da una persino assai abusata riserva culturale: se la lingua si presta, per economia, a far morire le metafore, allora accostamenti tra lemmi spesso usati nel quotidiano possono dar vita a sguardi più freschi e intuitivi. Tovaglia e mare si congiungono, quindi, nei versi: e il rimando è all’apparecchiare (una situazione, un incontro, una visione) operata da un autore, alla convivialità del sedere allo stesso tavolo (quasi etnologica nota costitutiva del la socialità umana), mentre il contrasto tra una stoffa che ricopre inerte e la vibrante e sempre profonda motilità del mare suggerisce che la parola poetica non si poggia solo denotativa sulla pagina del mondo, ma lascia tralucere dal suo stesso corpo la voce del mondo e della coscienza che non sfugge se stessa. Curiosa davvero quest’arte, che si ritaglia spazi di concentrazione angusti e solitari, ma cha da questi spazi rinnova il dire, il pensare e l’abbracciare l’altro. Infatti leggiamo in Un mondo, “è un mondo ricavato dalla casa/ questa mia stanza/ circa tre per quattro/ esposta a sud e spesso alle intemperie/ dove maneggio il corso dei pensieri/ tra impolverate enciclopedie/ e foto col sorriso di mia madre/ In questo spazio/annoto spaesamenti”. Anche il ritrarsi del dettato tra il primo e il secondo verso indica il ritirarsi del poeta in spazi più chiusi, in una stanza con due lati più lunghi di un solo metro rispetto alla cucina tre metri per tre metri per tre metri abitata da Clov in Finale di partita di Beckett: forse questo metro guadagnato ci consentirà di sfuggire l’abisso del nulla? Il piccolo antro del poeta, comunque, non è sordo al mondo, ne è esposto anzi alle intemperie e dal polveroso calderone della memoria (culturale, le enciclopedie, e personale, la madre) offre non certezze, ma al contrario spaesamenti: quel farsi straniero, cioè, al già detto e al già imposto, che senza scansare il dolore, senza chiudere gli occhi rispetto allo svanire - al nulla che minaccia noi e i nostri affetti, le nostre e le altrui memorie, le nostre e le altrui idee, le nostre e le altrui cose – si offre come parola che porta scompiglio ad ogni abbrutito ingrigire. “E una voce che parte da lontano/ giunge a raschiare il cuore”, si concludono, infatti, i versi di Un mondo. Per scrivere poesie – e più in genere per vivere con generosità e gentilezza davvero umana, mi piace aggiungere - bisogna risvegliarsi dal letargo in cui siamo precipitati. Quand’anche fossimo ricoverati in un ospedale – tale, in effetti, ci comunica il poeta è il luogo d’occasione della lirica Polittico ai frusti giorni - e questo tempo fosse “di cassetti ingombri/ di cocci sparsi/ e linfe d’aggiustare/ forse un tardo/ tributo da pagare/ ai giorni di fulgore/ o ad avventure/ amabili e furtive”, la parola non frusta ci ricorderà ancora delle lievi possibilità dell’esistere, del dono di camminare come a passeggio, mano nella mano, con l’amante. Se nessuna risposta si potrà dare come ultimativa all’instabilità costitutiva degli umani, di certo è dell’incognito che parla il dettato del poeta: “e continua/ a sfuggire all’inventario/ l’esatta consistenza dei totali/ la radice quadrata delle pene/ e il quid che manca/ nelle sottrazioni”.
Per Elias Canetti il Dichter aveva uno specifico dovere, un irremovibile opporsi alla morte. Era questo l’atto etico per eccellenza, perché ciò che chiamiamo morte ha una sola intenzione, ammesso che questa intenzione esista, “la riduzione e lo svilimento della persona viva a oggetto che non vale nulla, a una semplice traccia, che non rappresenta nemmeno un milionesimo delle potenzialità che quella persona, da viva, avrebbe avuta”. L’epoca attuale è rapinosa e stordente. Sotto la polvere spessa – magari luccicante come il maquillage delle belle dive – ha cercato di seppellire le più intense aspirazioni e le più tenere memorie degli umani. Come un risucchio, come un gorgo i tempi si ostinano a trascinarle nei tubi di scarico della storia. Colpisce, nella raccolta, di Romano l’abbondanza di termini che contengano al loro interno la lettera r, la vibrante alveolare. Come se intendesse, spesso, suggerirci, il risucchio che ci trascina a fondo, ma insieme la tensione che si rivela necessaria per sgranchirsi dal pesantore che ha arrugginito il nostro dire e, chissà,in tal modo riescire a riveder le stelle. Con levità, arguzia, ironia, malinconia e perizia stilistica Tra il niente e la menzogna – che certo non a caso si conclude con tre liriche dedicate a tre donne violate dalla vita ma di cui ancora ci giunge il “grido di libertà” – “ con il perenne moto dello scandagliare della mente” (Amicizie perdute), ci apre quel sottile luogo di sospensione dove, Canetti docet, alla morte (e nulla e menzogna ne sono due facce) bisogna – con consapevolezza della estrema fragiltà di una tale ipotesi – comunque opporsi.

 Sezioni
Sezioni