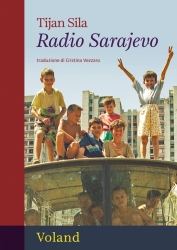di Marco Marino
Tra i tanti proverbi che spesso ripetiamo senza rifletterci troppo, ce n’è uno terribilmente insensato. È quel proverbio secondo cui non si dovrebbero giudicare i libri dalla copertina, ossia non si dovrebbe mai giudicare niente dall’aspetto esteriore.
Adesso, sull’assunto morale siamo tutti d’accordo, certo, ma l’esempio dei libri è molto infelice. Chiunque ami davvero la lettura, sa che per un libro la copertina, il titolo, l’impaginazione, la carta, il carattere dei paragrafi sono elementi essenziali. E non solo dal punto di visto estetico. La cura dell’edizione accresce, in modo direttamente proporzionale, la qualità letteraria delle pagine che scorriamo. Anche una pagina di Marcel Proust soffrirebbe in una “confezione” sciatta. Provate a leggere la Recherche nell’edizione dei Meridiani Mondadori e poi in quella Newton Compton, ne avrete una facile prova.
Ecco perché oggi vorrei consigliarvi un libro perfetto, nell’accezione editoriale dell’aggettivo. Si tratta della Marmocchietta del diavolo di Christine Lavant, tradotto da Anna Ruchat e pubblicato da La Grande Illusion, «una piccola casa editrice in divenire, con base a Pavia ma itinerante e cosmopolita d’elezione». Prima ancora del racconto di Lavant, a colpire è sicuramente il progetto grafico di Alice Beniero che ci introduce subito, già alla prima impressione, nel carattere labirintico, ossessivo e apparentemente impenetrabile del testo. La copertina, in questo caso, non è un vestito come un altro, ma un consiglio accorato al lettore, che lo mette in guardia sul rischio di perdersi all’interno della storia di Zita, figlia della serva guercia Wrga.

La fiaba oscura di Christine Lavant – autrice austriaca quasi sconosciuta in Italia, ma molto apprezzata nei Paesi d’oltralpe; tra le più amate dallo scrittore Thomas Bernhand – richiama un’antica superstizione carinziana, che paradossalmente potrebbe risultare molto prossima anche alla tradizione siciliana. Lavant scrive di una bambina che veniva considerata una «marmocchietta del diavolo»: secondo la leggenda, il diavolo era solito sostituire di nascosto gli infanti con bambini fisicamente o psichicamente menomati. La figlia di Wrga, però, sembra perfetta, solo crescendo il suo mutismo comincerà a essere considerato lo stigma di quell’infamia.
La vicenda sembra ricordare, con inquietante corrispondenza, una novella di Luigi Pirandello, La favola del figlio cambiato. Anche Pirandello attinge alla cultura popolare isolana per costruire la storia che diventerà il nucleo e l’anima del suo ultimo lavoro, I giganti della montagna. Nella versione pirandelliana, le madri del paese sono tutte legate da un’unica, grande paura: la paura che le Donne, figure arcane tra la vita e la morte, cambino i loro bambini con i figli del demonio.
In entrambe le versioni, tra «il marmocchio del demonio» e il figlio vero ci sarebbe un intimo legame di protezione e sopravvivenza, vigilato dalle madri effettive e demoniche. Ma la storia di Lavant non si ferma alla circostanza popolare, al resoconto della leggenda, alla rassegnazione delle madri, come fa Pirandello. Anzi, la sua narrazione inizia proprio dove finisce quella dello scrittore agrigentino. Lavant, infatti, indaga su come sarà, su quale sarà la vita riservata a una «marmocchietta del diavolo» in un piccolo villaggio rurale. Al di là della superstizione e dell’inesistente colpa.

Soffermarsi su questa connessione tra credenze così geograficamente lontane, ci porta a riflettere ancora una volta su quella che lo storico Carlo Ginzburg in Storia notturna. Una decifrazione del sabba chiama «una sotterranea mitologia euroasiatica». Una mitologia articolata e misteriosa, che lega gli sciamani del Friuli a quelli siberiani, i figli del diavolo siciliani a quelli austriaci, e ci fa sentire europei in modo inusuale: non solo come cittadini di una medesima organizzazione sovrastatale, ma soprattutto come comuni eredi di un patrimonio di fantasmi e di oscurità del tutto inesplicabili. Che ci unisce, forse, più di qualsiasi costituzione o parlamento.
Chiudendo questa breve nota, tengo a sottolineare una delle pagine più belle della Marmocchietta del diavolo. Ne potrei scegliere molte dal racconto di Zita, eppure quella che preferisco di più non è firmata da Christine Lavant. Per me la pagina più bella del libro è il suo colophon, la pagina finale, in cui l’editore riporta le caratteristiche tipografiche: «Stampato in offset dalla Fantigrafica di Cremona in una tiratura commerciale di soli 800 esemplari, con caratteri Kingfisher e Mr Eaves XL Sans su carta Fedrigoni Freelife Vellum White 120 g…». Ecco, se mi sono lasciato ammaliare da questo libro, se la storia di Zita e di Wrga mi è entrata dentro, il merito principale ce l’ha il colophon. Che mi ha convinto del fascino della lettura, ha ispirato il desiderio di iniziarla, e la speranza di ritrovare presto un’altra storia tanto preziosa. Sia all’interno che all’esterno
Avrò fatto bene, allora, a fidarmi della copertina.

 Sezioni
Sezioni