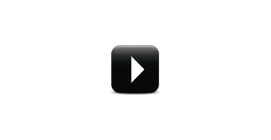Il Report di Adoc ed Eures sullo stato di salute della sanità pubblica in Italia mette nero su bianco il fatto che l'Italia è il Paese europeo che investe di meno nella Sanità pubblica.
Il progressivo disimpegno dello Stato italiano è certificato dalla riduzione della spesa sanitaria in termini reali, in flessione del 3,7% tra il 2021 e il 2022 e dello 0,8% rispetto al valore del 2020. Le previsioni di spesa riportate nel Def evidenziano un calo dell'incidenza della spesa sanitaria sul Pil. La spesa pubblica pro capite in Sanità si attesta, infatti, in Italia, a 2.180 euro, in Germania e in Francia si raggiunge, rispettivamente, i 4.641 ed i 3.766 euro per abitante. La Norvegia ha una spesa di 4.445, il Belgio 3.387 euro. Dopo l’Italia, soltanto la Grecia con una spesa sanitaria a persona di 1.196 euro. Se la Sanità pubblica diventa quasi inaccessibile le famiglie si rivolgono alla privata: tra il 2012 e il 2022, infatti, la spesa complessiva delle famiglie italiane è passata da 31,5 a 36,8 miliardi di euro, in media al mese si spendono in più 113,5 euro, al Sud la spesa si riduce a 97,3 euro al mese.
Non solo risorse economiche ma anche risorse umane che in Sanità pubblica iniziano a scarseggiare, il personale medico del SSN ammontava nel 2022 a 101.827 unità: lo 0,6% in meno rispetto al 2021 e il 2,7% in meno rispetto al 2012 (-7,5% al Sud), raggiungendo il -4,4% su scala ventennale. Ed è pure l’età media dei medici che fa la differenza: in corsia hanno più di 55.
Gli infermieri dipendenti del SSN sono 6,2 per 1 000 abitanti: un valore inferiore del 25% rispetto alla media Ue, pari a 8,5 per mille abitanti. Per adeguare l’Italia agli standard europei sarebbero necessari altri 100 mila infermieri.
A fronte di tutto questo cresce la mobilità sanitaria. Nel 2022, le prestazioni sanitarie erogate in una regione diversa da quella di residenza sono 19,2 milioni, con una crescita complessiva dell’8,1% rispetto al 2021 e del 42,1% rispetto al 2020.
La mobilità sanitaria si configura essenzialmente come migrazione dei cittadini dal Sud verso Nord, con un conseguente dirottamento di risorse economiche tra queste aree, con un volume negativo di -5,5 milioni di prestazioni per i residenti del Sud, assorbito in larga misura da quelle del Nord (+3,7 milioni).
Aumentate anche le prestazioni intramoenia del 16,7%, per oltre 1 miliardo di spesa. Queste prestazioni contribuiscono a sottrarre risorse ai cittadini per l’erogazione di servizi invece dovuti, alterando ulteriormente lo scarto nell’accesso alle cure in base alle condizioni economiche, si legge nel rapporto.
Dati allarmanti sono quelli di chi ha deciso di rinunciare alle cure: nel 2023 il 7,6% dei cittadini italiani. La rinuncia alle cure coinvolge primariamente le donne, tra le quali l’incidenza si attesta al 9%, contro il 6,2% tra i maschi. Rinunciano alle cure soprattutto persone in età mature: nella fascia 45-64 anni, infatti, il tasso di rinuncia alle cure raggiunge il 10,3%, scendendo lievemente (9,8%) tra i cittadini con almeno 65 anni di età, per attestarsi sui valori più bassi tra i giovani (2,6% tra gli under 25enni).
Adoc a fronte di questo scenario ha avanzato delle proposte: non sono più rinviabili investimenti nel comparto a partire dall’assunzione del personale, a condizioni lavorative dignitose e con garanzie retributive adeguate, al rilancio dell’edilizia ospedaliera per ovviare alla mancanza di posti letto e all’adeguamento degli ospedali più vetusti. Infine, occorre abbattere le infine liste d’attesa che di fatto stanno facendo aumentare gli squilibri territoriali, generazionali e di genere e che rischiano di amplificarsi ancora di più con la proposta di legge sull’autonomia differenziata. Ma tutto ciò implica anche una massima attenzione per la medicina territoriale e per la prevenzione attraverso la formazione: investimento necessario per ridurre le spese sanitarie di domani e per un sistema sanitario più sostenibile.

 Sezioni
Sezioni