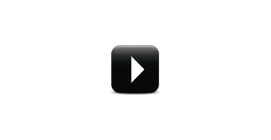C’era un’epoca, non così lontana, in cui il Canale di Sicilia veniva attraversato al contrario. Non era in Sicilia che approdavano i barconi. Anzi, era proprio da lì che partivano verso la costa nordafricana. Destinazione principale: la Tunisia. Furono molti i siciliani di Trapani, Marsala o Mazara che decisero di tentare la traversata, nella speranza di trovare in Tunisia ciò che non erano riusciti ad avere in Sicilia.
Verso il Maghreb: il “luogo dove tramonta il sole”
I primi emigrati furono operai, muratori, agricoltori e pescatori. Inizialmente partirono come manodopera temporanea o stagionale, poi vi si stabilirono. Onesti lavoratori in cerca di fortuna nella terra dove tramonta il sole. Troppo lontani gli Stati Uniti per poter sognare una vita nel Nuovo Mondo. Molto più vicina e meno costosa la Tunisia. Grazie ai rapporti economici e commerciali si venne a creare un flusso lento e costante verso la costa tunisina: tra la prima metà del XIX ed il XX secolo furono – si stima – quasi 100.000 gli italiani che partirono. Molti di essi erano siciliani, principalmente dalle province di Agrigento, Palermo e Trapani. Non soltanto uomini alla ricerca di un impiego ma anche piccola e media borghesia, imprenditori, proprietari terrieri ed esiliati politici. La presenza italiana si rivelò di fondamentale importanza per lo sviluppo economico della Tunisia. Nel giro di pochi anni, infatti, gli italiani divennero generalmente parte integrante del tessuto economico del paese. Si moltiplicarono le imprese, i negozi e le attività varie con titolari italiani.
Siciliani in Tunisia: “La Goulette” e “La Petite Sicile”
Camminare per le strade ed i vicoli di Tunisi, Biserta o Sfax significava immergersi in un continuo parlottio che mischiava arabo, francese ed italiano. Ogni città aveva la propria “Piccola Sicilia”. Non passò molto, infatti, prima che i tunisini dovettero imparare a comunicare anche in italiano, soprattutto nell’ambito commerciale. A testimonianza di ciò, basta ricordare che alcune parole sono rimaste cristallizzate all’interno del linguaggio comune dell’arabo tunisino ancora oggi. Economia, cultura e società subirono tutte l’influenza della presenza italiana. A nord di Tunisi sorse “La Goletta”: città costiera abitata principalmente da siciliani, divenne ben presto il centro nevralgico della vita commerciale degli italiani in genere in Tunisia. Negozi, botteghe, scuole ed istituzioni varie erano gestiti da siciliani. Alla Goletta si parlava siciliano, si mangiava siciliano, si viveva seguendo le tradizioni siciliane. Proprio dalla cittadina costiera prende il nome il “Trattato della Goletta” (1868), il quale designò l’Italia come “nazione favorita” ed incoraggiò l’immigrazione italiana in Tunisia. Con il tempo si venne a creare una vera e propria struttura sociale: venne costruito così il primo ospedale (1890), venne creata la Cooperativa Italiana di Credito (1900), iniziarono a nascere inoltre le prime forme di associazionismo in ambito commerciale. Furono fondate le prime banche (tra cui la Banca Siciliana), il quotidiano “L’Unione” e varie associazioni, teatri, librerie e cinema.
“Le péril italien”: storie di xenofobia e di colonialismo francese
Nei decenni successivi all’Unità d’Italia, la Tunisia divenne oggetto delle mire espansionistiche del governo italiano. Nel 1881, però, la Francia stabilì il proprio protettorato sul paese e, impossibilitata a cacciare la popolazione italiana presente nel territorio, decise di apportare misure che ne limitassero la libertà. Gli italiani – ed i siciliani in particolare- vennero descritti dalle autorità francesi come «criminali incalliti, irascibili, imprevedibili, violenti e molto pericolosi», alimentando così «il luogo comune del siciliano bellicoso, armato di coltello o di revolver, che uccide per futili motivi, [il quale] rimase fisso nel tempo» (Alì Noureddine: "Le cas de la criminalità sicilienne", Sousse 1888-98). I rapporti tra tunisini ed italiani – che negli anni precedenti all’istituzione del protettorato erano stati buoni – vennero lentamente minati dai francesi. Dopo gli anni '30 poi venne eseguito un processo di naturalizzazione forzata della collettività. I francesi fecero in modo che tutti i figli nati da cittadini europei diventassero automaticamente francesi. Ma non solo, tentarono di stabilire inoltre il divieto di esercizio delle professioni liberali a chi non fosse in possesso di un diploma francese e, successivamente, anche della nazionalità francese. Tali norme erano dirette soprattutto verso gli italiani. I rapporti politici tra Francia ed Italia in materia si incrinarono definitivamente con l’avvento del fascismo ed il tentativo italiano di non sottomettersi alle leggi draconiane imposte sul Protettorato tunisino.
Negli anni successivi molti italiani ritornarono nel proprio paese, soprattutto a seguito dell’indipendenza dalla Tunisia. Altri, invece, rimasero. Le loro sono storie di abbandono e di non ritorno, di nostalgia di casa e di spaesamento ma anche di opportunità e di successo. Sono testimonianze, voci mute di un passato storico che fa della Sicilia da sempre – e per sempre – terra di passaggio, tra emigranti ed immigrati.
Gianmarco Maggio - @GianmarcoMaggio

 Sezioni
Sezioni