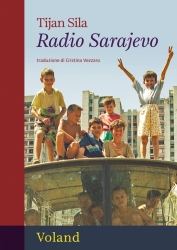di Marcello Benfante -
Che alla spedizione dei Mille garibaldini avesse partecipato una donna era un fatto abbastanza risaputo, talora ricordato perfino dai manuali scolastici, ma che sempre l’agiografia risorgimentale aveva sottaciuto o a limite confinato in un angolo pittoresco, fra le stramberie di un’impresa impossibile compiuta da eroi inverosimili: scrittori, pittori, musicisti, sognatori, visionari.
Quest’unica garibaldina, in certe aneddotiche e feuilletonistiche ricostruzioni, si sarebbe intrufolata clandestinamente tra le file dell’equipaggio, indossando abiti maschili per rendersi irriconoscibile. Oppure, una volta smascherato il suo travestimento, si sarebbe limitata a compiti di mera rappresentanza come una garbata quanto incongrua mascotte. Il fatto e la notizia, dunque, non erano che dettagli marginalissimi e fantasiosi di un grande affresco folclorico e mitologico.
Maria Attanasio, scrittrice che del metodo storico ha fatto il motore della sua narrativa, ha invece posto al centro della sua ricerca e del suo ultimo documentatissimo romanzo (“La ragazza di Marsiglia”, Sellerio, pagine 386, euro 15) questa figura femminile così ingiustamente lasciata in ombra, consegnandoci il suo ritratto interiore, la sua biografia, il suo ruolo tutt’altro che secondario nell’avventura garibaldina e nel processo, drammatico e lacerante, di fondazione della nazione italiana.

Il ritratto di Rosalìe Montmasson, prima moglie di Francesco Crispi, nata a Saint Joroz nel 1823, diventa così il ritratto in filigrana di una patria tradita, di un ideale corrotto e mortificato, di un “principio sì giolivo” che “ben conduce”, per citare a nostra volta e con medesimi intenti i versi del Boiardo citati ironicamente da Sciascia nell’esergo de “I pugnalatori”, ricostruzione della congiura palermitana del 1862.
Ed è singolare e amarissima ironia il fatto che la nascita del Regno d’Italia nel 1861, sotto l’egida dei Savoia, sia coincisa con la damnatio memoriae della fiera e selvaggia savoiarda che così attivamente e generosamente si era prodigata, dapprima sulle orme di Crispi, affinché quel sogno collettivo, sebbene di una sparuta minoranza, si realizzasse.
In questo senso il romanzo di Maria Attanasio non si limita a recuperare un volto, un’identità sommersa dall’oblio degli esclusi della Storia ufficiale, restituendoci una protagonista cancellata da un’epopea tutta al maschile, troppo spesso mistificata e mistificante, ma si inserisce con forza nel dibattito politico-storiografico, ancora attualissimo, sul nostro Risorgimento.
Moltissime, per esempio, sono le assonanze con il malinconico “Noi credevamo” di Anna Banti, lamento di un’atroce disillusione generazionale, che potremmo leggere anche in una chiave più moderna come castrazione dell’idea rivoluzionaria.
Muovendosi ancora una volta nel solco del romanzo storico manzoniano (“misto di storia e di invenzione”), recuperando anche in questa occasione un frammento di memoria locale della sua Caltagirone (l’intenso cammeo dedicato allo scultore Salvatore Grita, ennesimo tra i ripudiati), Maria Attanasio con la ricostruzione paziente e appassionata della personalità di Rosalìe-Rosalia Montmasson, unita al recupero di tante vite ammirevoli e perdute, compie un movimento contrapposto alla demolizione di una parte del nostro passato e delle nostre verità negate. Un’operazione di ripristino memoriale che potremmo paragonare all’ipotetica ricostruzione di un monumento, ancorché privo di retorica, che il vandalismo del potere costituito avesse sfigurato e abbattuto.

Da questo lavoro, originato da alcune apparizioni e coincidenze che sembrano suggerire la volontà di riaffiorare alla coscienza dei posteri di un personaggio in cerca di un testimone, ma poi condotto con rigorosa metodologia di ricerca, emerge l’altro Risorgimento: democratico e repubblicano, femminile e meridionale.
Un Risorgimento rifiutato ed emarginato, un grande movimento popolare sconfitto e rinnegato, che inizia ufficialmente con lo scioglimento dell’Esercito meridionale, forte ormai di circa cinquantamila uomini, per volontà di Vittorio Emanuele II, ma che forse già aveva registrato episodi misteriosi come la morte di Rosolino Pilo, ucciso probabilmente da fuoco amico (e forse non proprio amico) a San Martino delle Scale poco prima della presa di Palermo.
Poi fu la volta nel ’63 dell’omicidio del generale Giovanni Corrao, uomo incorruttibile che aveva rinunciato al grado di colonnello nell’esercito regio, che fu eliminato dalla mafia e calunniato egli stesso d’essere mafioso.
Pagine torbide di un'altra storia, quella dei vinti, fermata in Aspromonte.
Come ha scritto Alessandro Leogrande, “se c’è qualcosa di interessante (storicamente, politicamente e culturalmente) nell’Ottocento italiano, a parte il travagliato e in alcuni casi tragicomico processo unitario, è il confronto serrato, acceso, spesso virulento tra moderati e democratici, tra savoiardi e repubblicani. È il vedere come questo attrito abbia sprigionato acute riflessioni, balzi in avanti, e un intreccio tra pensiero e azione spesso lungimirante” (in “L’altro Risorgimento”, edizioni dell’asino, 2017).
La parte più saggistica del romanzo di Maria Attanasio è dunque una requisitoria, altrettanto rigorosa che indignata, contro quella che potremmo definire la mala nascita dell’Italia, contrassegnata da preventive epurazioni e da losche manovre di coercizione. La tesi insomma del “Gattopardo”, tra le tante voci di dissenso (pensiamo soprattutto, ma in tutt’altra direzione, a Sciascia e a Consolo).
Ma al tempo stesso una tesi che denuncia l’ideologia gattopardesca. La cui formula, ricorda Maria Attanasio, sebbene “citatissima” non è quasi mai riportata nella sua interezza “che ne dilata il significato storico”, chiarendone il preciso intento.
Tancredi afferma, con un cinismo che non potrebbe essere più circostanziato: “Se non ci siamo anche noi, quelli ti combinano la repubblica. Se vogliamo che tutto rimanga così com’è, bisogna che tutto cambi”.
È il pericolo della repubblica il primo a dover essere scongiurato dalla classe dominante, e non solo ovviamente in un’ottica di conservazione dei privilegi di casta siciliani e meridionali. Per una strana omissione, questa premessa fondamentale del teorema di Tancredi viene sistematicamente sottaciuta, forse ritenendola (a torto) fin troppo ovvia per un opportunista aristocratico.
Da qui una semplificazione fin troppo schematica della dialettica politica attraverso cui si stabilisce l’atto costitutivo del nuovo Stato.
“Nella Sicilia della seconda metà dell’Ottocento, non c’era infatti solo il noi del trasformismo politico dei nobili Salina e dei parvenu Sedara, ma anche il protagonismo sociale e politico di quelli”, scrive Attanasio.
Tra i riconvertiti filo-sabaudi e gli sciacalli, tra i più o meno probi Chevalley e gli arrampicatori sociali alla Sedara, tutti pronti, per dirla con De Roberto, a farsi gli affari propri, ora che l’Italia è fatta, ci sono anche “quelli”: il terzo escluso, ossia il partito disperso dei mazziniani, dei democratici, dei socialisti. E le plebi rurali massacrate, come a Bronte, come ad Alcara Li Fusi, la ferocia pressoché ingovernabile dei contadini esasperati da una lunghissima fame di pane e di diritti.
I cafoni fatalmente condannati al brigantaggio e poi alla spietata repressione del brigantaggio. E poi ancora al sottosviluppo e all’emigrazione di massa. All’estenuante battaglia della cosiddetta questione meridionale.
È una storia, quella d’Italia, in cui accade che i “noi” si alternino al potere o lo condividano, ma “quelli” ne restano sempre fuori.
“Quelli, però sempre vinti. E sempre invisibili nella narrazione dei vincitori: relegati nell’inesistenza storica e, con pochissime eccezioni, anche letteraria”, afferma causticamente la Attanasio.
È la grande “rimozione” che consente di perpetuare l’immagine di una Sicilia statica eternamente ripiegata su se stessa, “e di un Risorgimento siciliano, tutto compromessi e trasformismo, senza gli slanci ideali e la connotazione democratica e libertaria che invece ebbe”.
A quest’altra storia, sottratta e occultata, forse allude ambiguamente il personaggio del “Ciambellano del Cifrario”, ossia Alberto D., segretario particolare di Crispi, a metà tra finzione e verità, il cui compito consiste nel manipolare l’informazione e la comunicazione secondo i codici sempiterni del potere. Eppure, segretamente, questo criptatore e decriptatore dei linguaggi diplomatici, aspira a scrivere “un grande romanzo – insieme epico e demistificante – sul Risorgimento”. Un romanzo capace di recuperare l’evento per mezzo del vissuto, fatto di uomini e sentimenti, di una “lingua-anima” in grado di raccontare “l’eroica follia di quei pazzi senza ritorno, che avevano costituito l’ossatura del Risorgimento”, con una scrittura lenta, “lumaca e Penelope”, che cuce e scuce infinitamente la sua tela.
Un romanzo, inutile dirlo, che non vedrà mai la luce. Ma che in parte prende corpo proprio nelle pagine de “La ragazza di Marsiglia” e che certamente costituisce un’ambizione, ancorché mitigata, della stessa Attanasio.
E se l’attenzione della scrittrice pare tutta concentrarsi, a partire dal titolo e dalla motivazione originaria, sull’omaggio e la restituzione morale alla figura a suo modo emblematica di Rosalìe Montmasson, tale figura risulta la chiave con cui decifrare e dischiudere tutto un mondo di cospiratori e sognatori, tutto un intreccio di progetti e imposture, di rivolte e tradimenti, di fedeli perseveranze e opportunistiche metamorfosi. Ossia tutto quel complesso di contraddizioni che in sintesi chiamiamo Risorgimento.
Al ritratto di Rosalia corrisponde in contraltare quello di Crispi. L’una è un temperamento volitivo e concreto, una donna dotata di senso pratico e di incrollabile determinazione che si procura anzitempo il “libre consentement” che l’autorizza a sposarsi anche senza il consenso paterno. Selvatica e orgogliosa, la Montmasson è una “capra montana” e “senza paura”, indipendente e gagliarda nella sua gioventù indomabile, che non confonde mai il rispetto con l’obbedienza. Una combattente non dissimile dall’Anita di Garibaldi (e forse proprio per questo autorizzata dall’Eroe dei due mondi a imbarcarsi a Quarto, unica eccezione a un divieto perentorio) che sa maneggiare armi ed esplosivi, ma anche condurre missioni delicatissime di collegamento con gli esuli clandestini. Una donna forte e generosa, disposta talora a fare un passo indietro per non danneggiare il marito nell’infuriare mediatico e politico dello scandalo durante il processo per bigamia.
All’opposto troviamo la fisionomia camaleontica di Francesco Crispi, in gioventù mazziniano e rivoluzionario, poi sempre più integrato nel sistema monarchico, sempre più coinvolto in un programmatico doppiogiochismo, a metà strada fra destra e sinistra, tra riforme e restaurazione, tra istanze progressiste, sempre più labili, e repressione, sempre più dura, a cominciare da quella di Bronte fino a quella dei Fasci siciliani. E poi il suo groviglio interiore, l’abisso del suo cuore contraddittorio, la sua incontenibile sensualità, il suo inguaribile gallismo, e al tempo stesso la sua schizofrenica fedeltà a Rosalie, la donna sposata a Malta e rinnegata, amata e tradita, a cui tuttavia resterà oscuramente legato fino alla fine. “Un genio in politica, ma un balordo nel privato”, dice di lui il suo segretario. Abbindolato a causa delle sue bramosie, specialmente quelle senili, e quindi travolto dai pettegolezzi, dallo scandalo, dalle accuse, in un declino indecoroso.

Un Crispi quindi pre-mussoliniano (e in qualche modo anche pre-craxiano) in certi suoi atteggiamenti nazionalisti e autoritari, nei suoi modi spregiudicati e maschilisti, in certo suo machiavellismo (o guicciardinismo, come parve a Mazzini) voltagabbana, nella manipolazione dell’informazione, in cui possiamo trovare in nuce tutti i grandi disastri e i mali antichi della politica italiana (dal militarismo alla débâcle di un infame colonialismo, dagli intrallazzi finanziari ai compromessi opportunistici, dalla corruzione all’uso strumentale della legge, dalla Realpolitik al velleitarismo).
Maria Attanasio confessa che “cercando Rosalia” si è trovata casualmente a incontrare “tante vite esemplari e straordinarie”. Non sempre nel bene, potremmo aggiungere, ché il suo romanzo è un grande affresco corale, plurale, discordante, in cui si esprime in rapidi tocchi di colore tutta l’estrema complessità del nostro travaglio storico. Sono pagine che avvincono, indignano, commuovono (toccanti per esempio quelle dedicate al funerale di Mazzini), che pur basandosi su un’accurata e meticolosa escavazione delle fonti, a tratti assumono anche i toni sentimentali del racconto popolare, così consoni d’altronde a un certo romanticismo risorgimentale, intriso, nel bene e nel male, di melodramma.

 Sezioni
Sezioni